3/4/2020
I venerdì fiabasofici
Autore: Giancarlo Chirico
La felicità dell’uomo non resta mai nello stesso punto.
Erodoto
In questi tempi un po’ balordi, nei quali il tempo sembra essersi fermato e i nostri pensieri tendono ad accartocciarsi intorno a un senso neanche tanto velato di paura e di inquietudine, ho riletto con rinnovata attenzione questo bellissimo albo edito da Zoolibri, scritto da Davide Calì e magicamente illustrato da Gianluca Folì.

Un albo dallo straordinario piglio narrativo – profondo, problematico, mai banale – che si spiega lungo un bianco sempre presente, che in altri albi avrebbe fatto semplicemente da sfondo e che qui, invece, è assoluto protagonista. A partire dalla copertina: una scimmia bianca spunta dalle fronde di un albero, osservandomi a testa in giù – il rovesciamento di ogni prospettiva – e mi porge un fiore bianco… che gentile! Ma il retro della copertina racconta altri sorprendenti aspetti di questa simpatica scimmietta: scarpe all’ultima moda e una coda tutta sporca, con qualche fogliolina ancora attaccata. Possibile che questa scimmia cammini con le scarpe?
Siamo già dentro la storia: la scimmia si chiama Bruno, vive in uno zoo e ama osservare gli uomini che la osservano. Ancora una volta il ribaltamento della prospettiva, oggetto e soggetto: io guardo il mondo, ma il mondo mi osserva e muta continuamente sotto i miei stessi occhi, così come – ne dovrei pur essere conscio – io muto sotto i suoi occhi.
Ancora una volta il ribaltamento della prospettiva, oggetto e soggetto: io guardo il mondo, ma il mondo mi osserva e muta continuamente sotto i miei stessi occhi, così come – ne dovrei pur essere conscio – io muto sotto i suoi occhi.
A Bruno piacciono i vestiti, ma – osserva giustamente la mamma – lui è una scimmia: che se ne fa dei vestiti? Basta una frase per ristabilire di colpo le tradizionali prospettive: tu sei una scimmia, fai la scimmia, sarai una scimmia, farai sempre la scimmia! Quando i pregiudizi sono così forti da impedire ogni cambiamento e disinnescare ogni trasformazione, siamo costretti ad arrenderci: Il mondo non cambierà mai! Ma Bruno è più forte dei pregiudizi: e, infatti, lo vediamo subito a testa in giù e, poi, nella doppia pagina successiva, più vicino a una famigliola umana – che, chissà come, si è ritrovata su un alto ramo dello stesso albero – che alla sua. Eh sì, perché Bruno ha imparato a capire la lingua umana e ha scoperto che una volta gli uomini erano scimmie: quindi – ah, l’infallibile logica aristoteliana! – anche lui un giorno potrà diventare una persona! I milioni di anni dell’evoluzione umana, i suoi svariati tentativi e i numerosi fallimenti, si condensano in pochi attimi e quasi annichiliscono davanti allo sguardo curioso e divertito della scimmietta che comincia a sognare: nonostante la mamma lo rassicuri che non è possibile, lui sogna, sogna forte, quasi ad alta voce! E noi lo sentiamo distintamente.
E dopo il sognare – inesorabile, puntuale, quasi liberatorio – giunge il pensare: dal mito alla filosofia, il passaggio si ripete ogni volta uguale a se stesso. Bruno comincia a ‘riflettere’: “Cosa vuol dire?”, gli chiede il padre. “È come pensare. Però più forte”, risponde Bruno. “E a cosa serve”, incalza il papà. “Non lo so, forse a niente. È solo bello”.
Giunge intrigante e inaspettato questo giudizio estetico da parte di Bruno: quando una potenza è agli albori della sua realizzazione, quando ancora non ne conosciamo tutte le possibilità, quando ne percepiamo appena il significato, la portata, le vibrazioni di fondo, non sappiamo bene in cosa, non sappiamo bene come, ma ci piace, è bello. Bruno forse non conosce ancora la parola, ma Kant gli avrebbe suggerito ‘sublime’: è l’energia intensa e primordiale con la quale il pensiero pensa se stesso, si pro-voca e si stupisce quando le cose prendono forma e si fanno più chiare e definite. La bellezza dell’atto originario del demiurgo formatore del mondo!
 Succede che un gesto apparentemente banale – che a Bruno serve per conciliare pensieri e riflessioni – viene notato da alcune persone che vogliono fare di lui una vera e propria star. In un solo istante, si consuma subito il distacco con la propria gente: “forse diventerai una persona come desideri. Ma allora credi che sarai più felice? Ecco rifletti su questo”, gli dice il padre. Insomma, credevo di avere tra le mani un albo che parlasse di identità e, invece, il padre di Bruno solleva un’altra questione, destinata a diventare centrale: dove risiede la felicità di una persona?
Succede che un gesto apparentemente banale – che a Bruno serve per conciliare pensieri e riflessioni – viene notato da alcune persone che vogliono fare di lui una vera e propria star. In un solo istante, si consuma subito il distacco con la propria gente: “forse diventerai una persona come desideri. Ma allora credi che sarai più felice? Ecco rifletti su questo”, gli dice il padre. Insomma, credevo di avere tra le mani un albo che parlasse di identità e, invece, il padre di Bruno solleva un’altra questione, destinata a diventare centrale: dove risiede la felicità di una persona?
Finalmente, Bruno si avvicina agli umani: diventa come loro, veste, parla e si muove come loro, impara addirittura a suonare uno strumento musicale, ed è bravissimo. Ma l’evoluzione darwiniana non può essere condensata in poche pagine: e, infatti, Bruno non è una persona, non gli assomiglia neanche lontanamente! È bravo a parlare, per essere una scimmia; veste molto elegante, per essere una scimmia; ma puzza, puzza proprio come una scimmia. E, ritornando alla questione sollevata dal padre, Bruno per la prima volta si fa dubbioso: probabilmente, una scimmia può essere felice solo in mezzo ad altre scimmie…
 Alla fine, decide di tornare allo zoo, solo che neanche lì è felice: l’incomunicabilità con la propria specie è diventata totale, nessuno vuole sentirlo suonare, nessuno lo capisce quando parla. Ed è reciproca: a Bruno non piace essere nudo e, soprattutto, non sopporta la puzza di scimmia! Ebbene sì: Bruno sente le scimmie puzzare – proprio come le persone sentivano Bruno puzzare.
Alla fine, decide di tornare allo zoo, solo che neanche lì è felice: l’incomunicabilità con la propria specie è diventata totale, nessuno vuole sentirlo suonare, nessuno lo capisce quando parla. Ed è reciproca: a Bruno non piace essere nudo e, soprattutto, non sopporta la puzza di scimmia! Ebbene sì: Bruno sente le scimmie puzzare – proprio come le persone sentivano Bruno puzzare.
C’è questa doppia pagina che trovo geniale! Sfondo bianco, nuvoloni densi e grigi, come ricordi sfumati e sbiaditi, oppure come presenze vaghe ma minacciose: una forma di scimmia, altera, distaccata, un po’ ostile e due braccia che provano a cingere, solo che non mi sembra abbiano intenzioni amichevoli, si addensano intorno a Bruno che, a sua volta, non è affatto aperto e conciliante. Tutt’altro: si copre il naso, sente la puzza – quasi la sentiamo anche noi! – in un gesto che è di vera chiusura. Ricordo che ai corsi di teatro una delle prime cose che insegnano agli aspiranti attori è: rivolti sempre verso il pubblico e mai coprire la bocca, altrimenti la voce non arriva a nessuno! Ebbene, è evidente che Bruno non vuole proprio arrivare da nessuna parte; e non vuole che niente da fuori gli arrivi!
“La creatura più sola dell’universo”: e la solitudine, sovente, genera ostilità. Ma, soprattutto, genera desolazione.

Folì ci regala un’altra straordinaria doppia pagina: Bruno, di pelo bianco, che quasi scompare nel bianco dello sfondo (vi ricordate cosa dicevamo della funzione del bianco in questo albo?); è una figura scontornata, senza alcuna definizione, senza identità. Le mani sono intrecciate, trasmettono paura; i piedi sono spaiati: uno è nudo, l’altro ha una scarpa… Né scimmia, né umano!
Ciascuno, nella propria irripetibile unicità, è solo: il fatto è che se ci abbandonassimo a questo radicale convincimento saremmo destinati a essere infelici per sempre! Ma per fortuna il mondo sa sorprenderci: Bruno incontra Greta, una scimmia come lui che, proprio come lui, non vuole essere una scimmia, anche se non riesce a essere come un umano. Una scimmia che sa suonare, sa parlare, ama vestirsi…
E proprio nel momento in cui la storia sembra dipanarsi, succede qualcosa di molto profondo, che ci invita ancora una volta a riflettere: nell’abbraccio di Buno e Greta – dovremo ritornare su questo tema! – le due identità (che fino a quel momento si erano definite solo in termini negativi: né questo, né quello) riescono finalmente a trovare il proprio centro. Un semplice gesto diventa la chiave narrativa per rivelare qualcosa di prodigioso: il riconoscimento di sé a partire dall’altro è il fondamento di ogni sincera autoconsapevolezza ed è in grado di spazzare via ogni pregiudizio e di aprire all’autentica felicità.

Vi ricordate quel che aveva detto il papà a Bruno? Prova a riflettere sulla felicità e sul fatto che essa possa dipendere o meno dal tuo essere scimmia o essere umano! Ebbene, Bruno ora ha la risposta: “so di essere stato una scimmia” – e ora non lo sono più – “e so di non essere una persona” – e ora so che non lo sarò mai veramente! Eppure, da questa doppia negazione, che in altri momenti sarebbe stata fonte di angoscia, prendono forma tutte le mie possibilità e la mia felicità si scopre totalmente libera (e la mia libertà finalmente felice!). E questo prodigio ha solo un nome: Bruno!
Calì, G. Folì, La scimmia, Zoolibri 2014
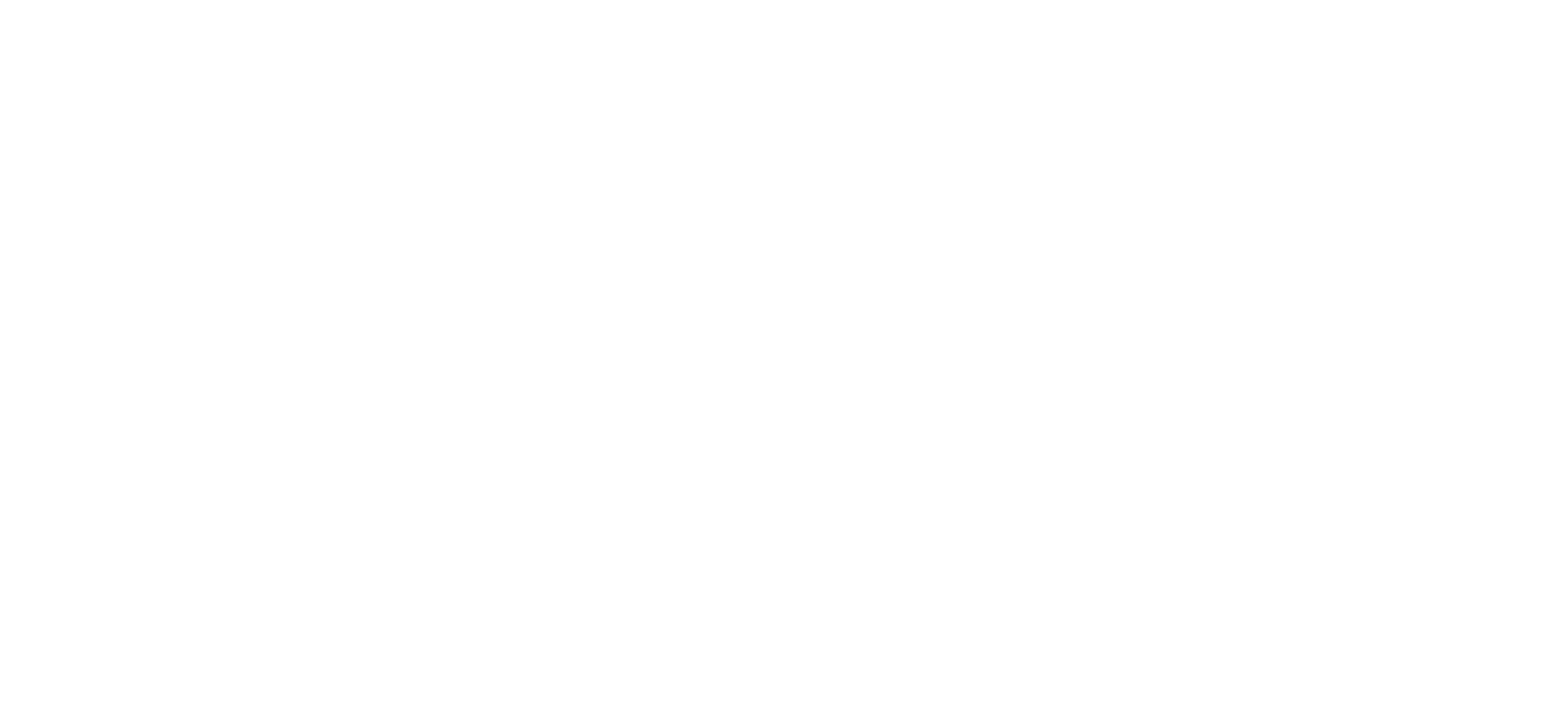







 È quel che succede a chiunque abbia a che fare con i bambini (una classe, un gruppo di lettura, una comunità di ricerca): passi dal gruppo al singolo, dal coro all’assolo, con uno sguardo forse un po’ strabico, quasi divergente, ma sempre dinamico e puntuale. In verità, è quello che succede in ogni relazione autentica: ci avviciniamo per accostarci all’altro, alle sue ragioni, alla sua particolare prospettiva ma, al contempo, abbiamo bisogno di vedere l’insieme, le connessioni, le relazioni tra il suo punto di vista e il mio. Da qualche parte ho letto che questo albo ci costringe a fare fisicamente l’esercizio ‘dei doppi occhiali’ che i presbiti imparano presto a fare: e a ogni cambio di lente, le informazioni aumentano, i contorni cambiano, le figure si arricchiscono di particolari e l’insieme si dettaglia più in profondità. La trovo proprio una bella immagine.
È quel che succede a chiunque abbia a che fare con i bambini (una classe, un gruppo di lettura, una comunità di ricerca): passi dal gruppo al singolo, dal coro all’assolo, con uno sguardo forse un po’ strabico, quasi divergente, ma sempre dinamico e puntuale. In verità, è quello che succede in ogni relazione autentica: ci avviciniamo per accostarci all’altro, alle sue ragioni, alla sua particolare prospettiva ma, al contempo, abbiamo bisogno di vedere l’insieme, le connessioni, le relazioni tra il suo punto di vista e il mio. Da qualche parte ho letto che questo albo ci costringe a fare fisicamente l’esercizio ‘dei doppi occhiali’ che i presbiti imparano presto a fare: e a ogni cambio di lente, le informazioni aumentano, i contorni cambiano, le figure si arricchiscono di particolari e l’insieme si dettaglia più in profondità. La trovo proprio una bella immagine.



