Frida allo specchio!
di Giancarlo Chirico
È indubbio che lo specchio rappresenti uno degli oggetti (fiabeschi e non) più affascinanti e densi di significato. In primis, perché riflette quel che tu sei, restituisce ai tuoi occhi l’immagine che porti in giro per il mondo, senza alcun filtro o effetto speciale: lo specchio sa essere veritiero fino alla crudeltà. E così, cara strega, pur riconoscendo la tua bellezza, non può non declamare quella superiore di Biancaneve, lasciandoti lì a riflettere sulle ragioni che dovrebbero giustificare quella che a te pare una beffa cocente…
Ma lo specchio è anche un confine tra la dimensione fisica delle cose reali e quella impalpabile delle proiezioni immaginarie: come tutti i confini (o – pensando alle suggestioni filosofiche di Suzy Lee – come tutti i limiti), lo specchio esiste nella misura in cui può essere violato, attraversato, superato.  Solo colui che osa guardare attraverso di esso può conoscere quel che veramente si nasconde dall’altra parte: e non è detto che tutto ciò sia meno reale… Alice, non potendo più calarsi per un albero cavo, esercita il proprio diritto di cittadinanza attraversando uno specchio e giungendo così per la seconda volta nello spazio abitato dalle più grandi meraviglie, dove la riflessione su se stessa può procedere senza inutili formalismi…
Solo colui che osa guardare attraverso di esso può conoscere quel che veramente si nasconde dall’altra parte: e non è detto che tutto ciò sia meno reale… Alice, non potendo più calarsi per un albero cavo, esercita il proprio diritto di cittadinanza attraversando uno specchio e giungendo così per la seconda volta nello spazio abitato dalle più grandi meraviglie, dove la riflessione su se stessa può procedere senza inutili formalismi…
Infine, lo specchio è il luogo dei rovesciamenti, delle condizioni ribaltate, delle prospettive che si sovrappongono anche quando sono opposte: tu alzi il braccio destro ma lo specchio ti fa vedere quello sinistro, tu pensi che sia questo e, invece, si tratta di quello; un’opposizione che, in questo spazio, risulta sorprendentemente componibile.
Chissà se avrà pensato a tutto questo Guillermo Kahlo Kaufmann allorquando, vedendo la figlia Frida completamente paralizzata su un letto, con le ossa frantumate in migliaia di dolorosi frammenti e lo sguardo spento dinanzi a una prospettiva di polvere e silenzio, decise di montarle (ma chi c’avrebbe mai pensato?) uno specchio sopra il suo letto…
Chissà se avrà pensato che, ponendola di fronte a quello specchio, la figlia sarebbe stata finalmente libera, non più preda della grigia disperazione ma capace di volteggiare con un nuovo paio di ali colorate.
Bellissima la doppia pagina che Michelangelo Rossato – nel suggestivo albo Frida Kahlo nella sua Casa Azul (Arka edizioni), con testi di Chiara Lossani – ha dedicato a questo “momento” potentissimo, durato quasi due anni: Frida Kahlo si guarda allo specchio. O meglio, non si guarda soltanto, ma si osserva, si scruta, si conosce e si riconosce in profondità.
E che si tratti di un momento cruciale nella vita di una ragazzina destinata a essere la più grande pittrice del secolo scorso, l’albo ce lo suggerisce allorché, per guardare l’illustrazione nel verso corretto, dobbiamo rovesciarlo e cambiare punto di vista: si tratta di una soluzione tecnica che ha autorevoli precedenti e che Michelangelo aveva già sperimentato in La Sirenetta. Ma qui i due soggetti che si fronteggiano sono la stessa persona: Frida e la sua immagine possono finalmente guardarsi reciprocamente; e noi – fuoricampo – assistiamo a un confronto intenso e autentico, senza facili scappatoie per nessuna delle due.
Sotto c’è Frida in carne e ossa, paralizzata, libera di muovere appena un braccio, con una tavolozza senza alcun colore, senza ispirazione, senza possibilità. Sopra c’è Frida in immagine e potenza, la Frida che vuole liberarsi da quella cruda prigionia e che vuole colorare il mondo intero: la Frida che vuole essere, con forza e audacia, che vuole librarsi e dare un senso alla totalità della propria sofferenza. Ma la doppia pagina illustrata da Rossato – e l’intensità dei due sguardi che s’incrociano – solleva almeno un interrogativo: siamo proprio sicuri che l’unico sguardo sia quello della Frida reale, grigia e sofferente, verso la sua immagine allo specchio, colorata e determinata? Non è forse possibile che quest’ultima Frida osservi a sua volta la prima e la scruti alla ricerca di un guizzo vitale che possa dare corpo alle possibilità ch’essa sente di rappresentare?
Perché, in questo prodigioso spazio di rovesciamenti, tutto è veramente possibile: anche che sia l’immagine nello specchio a riflettere, a sua volta, sul corpo che la proietta e la produce, rivelando nuove e inaudite forme di consapevolezza. A ben vedere, l’immagine allo specchio è allo stesso tempo ciò che siamo di qua dallo specchio e quel che possiamo diventare di là da esso, perché su questa soglia incerta e fragile abitano possibilità che vanno ancora scoperte ed esplorate. Frida deve averlo capito, tant’è che negli anni a seguire, per tutti i tormentati anni della sua straordinaria carriera, continuerà a dipingere prevalentemente autoritratti; e quando le chiesero le ragioni di questa sua scelta artistica, rispose semplicemente: “Dipingo me stessa perché passo molto tempo da sola e sono il soggetto che conosco meglio”.
È come se Frida, per tutta la sua vita, avesse continuato a sperimentare e a dare corpo alle infinite possibilità – alcune ricche di risvolti positivi, altre (purtroppo) cariche di dolori – che nei lunghi mesi dell’immobilità aveva imparato a scorgere nel riflesso dello specchio: ora indigena circondata da gatti, da scimmiette, da pappagalli, o da altri animali esotici, ora vestita completamente di bianco, ora cerbiatta in fuga, trafitta da decine di frecce e da un dolore indicibile.
E a noi, quante volte, ci capita di guardarci allo specchio? Decine e decine nella stessa giornata… ma lo facciamo solo per specchiarci in superficie o per guardarci in profondità, come seppe fare Frida? riusciamo a scorgervi il motore pulsante delle possibilità che siamo e che possiamo realizzare? A partire da queste domande, l’albo di Lossani e Rossato ci regala lo spunto per una divertentissima esperienza da vivere con i bambini: metteteli davanti a uno specchio e invitateli a osservarsi con attenzione, per cogliere le proprie caratteristiche da riprodurre poi in un ritratto…ebbene, ci regaleranno dei capolavori!

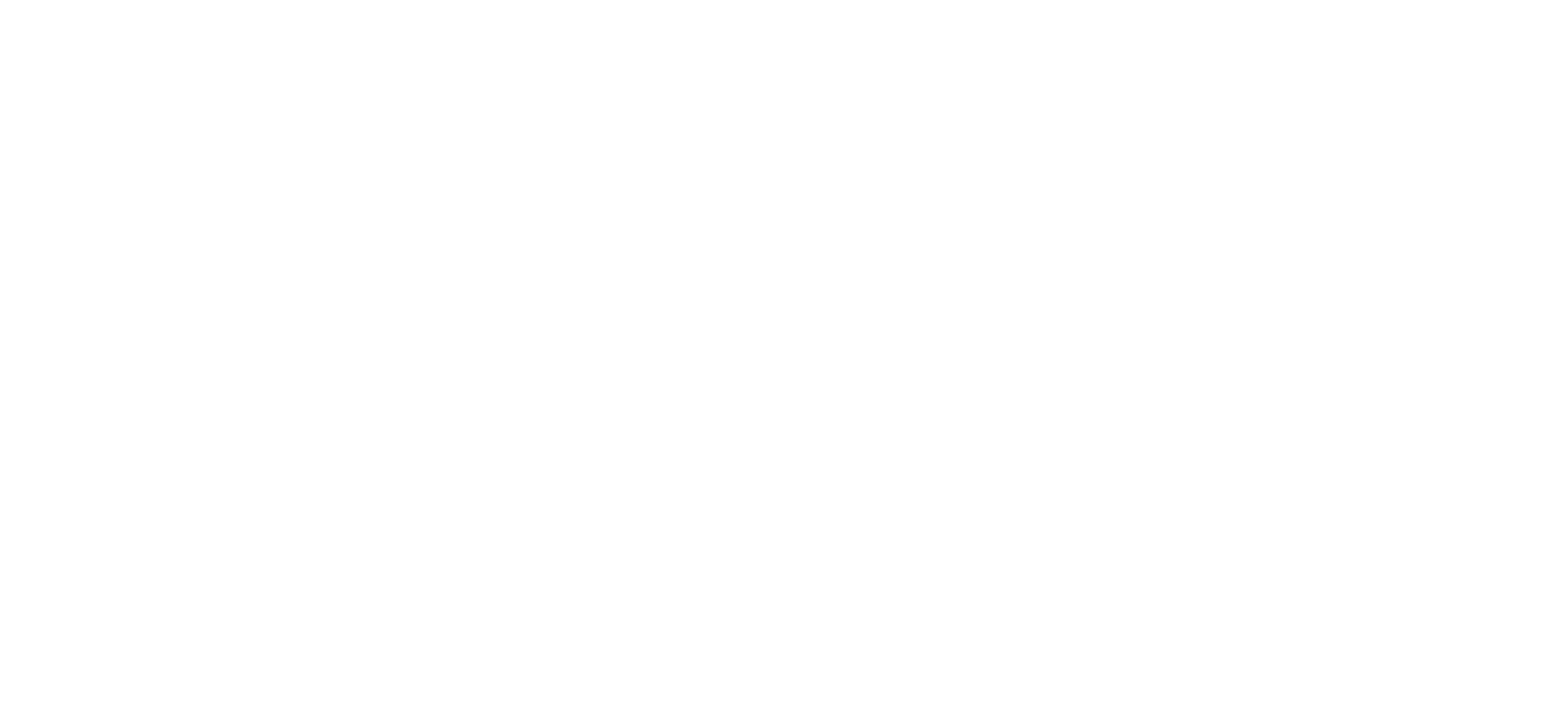

 Chi c’era forse ricorderà che si trattò di eventi caotici, concitati, in molti casi confusionari: non è facile riportarli alla memoria, anche a distanza di trent’anni, e tenere insieme le fila di narrazioni così articolate e complesse. A quest’anno e al suo simbolo per antonomasia è dedicato il densissimo albo di Orecchio acerbo, intitolato proprio 1989 e dedicato a tutti i muri – visibili e invisibili – della storia: dieci voci in un unico albo, che provano ad attraversare i muri e andare oltre la loro fisica assurdità. L’albo, nella dialettica serrata dei testi tra loro e con le visionarie illustrazioni di Henning Wagenbreth, restituisce un quadro ricco, articolato e nient’affatto lineare di un anno che ha segnato la storia del nostro continente.
Chi c’era forse ricorderà che si trattò di eventi caotici, concitati, in molti casi confusionari: non è facile riportarli alla memoria, anche a distanza di trent’anni, e tenere insieme le fila di narrazioni così articolate e complesse. A quest’anno e al suo simbolo per antonomasia è dedicato il densissimo albo di Orecchio acerbo, intitolato proprio 1989 e dedicato a tutti i muri – visibili e invisibili – della storia: dieci voci in un unico albo, che provano ad attraversare i muri e andare oltre la loro fisica assurdità. L’albo, nella dialettica serrata dei testi tra loro e con le visionarie illustrazioni di Henning Wagenbreth, restituisce un quadro ricco, articolato e nient’affatto lineare di un anno che ha segnato la storia del nostro continente.





 Davanti al bellissimo fiore che compare nella primissima doppia pagina dell’albo mi sono chiesto quanto sia stato arduo il compito di Nicoletta Bertelle, l’illustratrice del magnifico testo di Bernard Friot: mi sono immaginato i fogli che ha riempito con i suoi colori, le numerose prove e gli svariati tentativi di dar corpo all’inafferrabile; ho provato a sentire il pennello che fremeva sotto la mano, facendosi più leggiadro possibile, mentre nel cuore richiamava la voce del maestro di una vita, quello Štěpán Zavřel, che con il colore ha incantato gli sguardi di mezza Europa. Com’è stato possibile venire a capo di una prova artistica tanto notevole?
Davanti al bellissimo fiore che compare nella primissima doppia pagina dell’albo mi sono chiesto quanto sia stato arduo il compito di Nicoletta Bertelle, l’illustratrice del magnifico testo di Bernard Friot: mi sono immaginato i fogli che ha riempito con i suoi colori, le numerose prove e gli svariati tentativi di dar corpo all’inafferrabile; ho provato a sentire il pennello che fremeva sotto la mano, facendosi più leggiadro possibile, mentre nel cuore richiamava la voce del maestro di una vita, quello Štěpán Zavřel, che con il colore ha incantato gli sguardi di mezza Europa. Com’è stato possibile venire a capo di una prova artistica tanto notevole?



